Archive for July, 2017
Le foto di Obama, e quelle di Trump
Posted by gea in politica e dintorni on July 25, 2017
La settimana scorsa, a Cortona, sono incappata in una conferenza di Pete Souza, l’ex fotografo di Obama alla Casa Bianca. Non so dire se tecnicamente Souza sia un grande fotografo – stando ai parametri a volte perniciosetti per cui gli appartenenti a una categorie professionale parlano degli altri, specie se ancora vivi – ma so di certo che è stato eccezionale.
Magari non avete idea di chi sia ma avete comunque visto i suoi scatti, essendo stati sostanzialmente in mostra permanente sulla stampa intera per tutti gli anni della presidenza Obama: tra i meriti di Souza c’è quello di aver reso umano un mito e di aver mitizzato l’uomo.
Indice sommario: il presidente che gioca col bambino vestito da Spider Man, una corsa col cane Bo (e non chiedete perché Dudù non muove alla stessa tenerezza), un hamburger in maniche di camicia, una partitella a basket, oppure lui e Michelle in ascensore, a guardarsi negli occhi dopo una festa, o tutto lo staff nella situation room al momento dell’assassinio di Bin Laden eccetera eccetera.

È probabile che in questi anni le foto di Souza mi abbiano ammaliato anche per via dell’adorazione che ho per Obama (e no, non perché fosse un nero con una storia costruita ad arte. Trump almeno un merito ce l’ha: la differenza tra i due è così spaventosa che oggi nessuno può più dire che ci piaceva Obama solo perché era “diverso”). Mi sono chiesta più di una volta se mi stessi bevendo uno storytelling ben confezionato – che poi Filippo Sensi ha provato a imitare in modo un po’ grottesco con Renzi -, se stessi inconsapevolmente ripiegando tutto il mio spirito critico, se mi stessi ammalando ogni giorno di più di esterofilia e erbadelvicinismo, per così dire.
In parte; può essere. Non bisogna essere Asor Rosa per capire che, certo, nel portarci a un centimetro dalla faccia di Obama contratta dalla stanchezza Souza stava servendo un bon bon di benevolenza nella vita politica e nella capacità di giudicarla. Ci stava seducendo nemmeno troppo lentamente, scodellando l’immagine dell’uomo giusto e giudizievole, padre amorevole, marito appassionato, presidente sempre presente a se stesso senza perdere il lato giocoso, affabile, umano.
Non so voi, ma io di donne non innamorate di Obama non ne conosco. E di uomini politici di similsinistra che non abbiano provato a imitarlo, nei modi e nello stile, neppure.

In ogni caso mi ero quasi rassegnata a dimenticarmi dei momenti felici in cui la mattina aprivo i quotidiani e nel riquadro generalmente destinato a XFactor e alla ricetta del baccalà alla vicentina si trovavano gli ultimi scatti di Souza, quando l’ho sentito raccontare un aneddoto.
Stava mostrando una foto di Trump, preso di spalle, che entra nello Studio Ovale, probabilmente nei giorni del passaggio tra i due presidenti. Sullo sfondo un muro bianco occupato da un grande quadro.
«Ah, quel quadro non c’è più», ha buttato lì. «Quelli di Time hanno fatto un servizio di recente: hanno scattato dalla stessa posizione e ora su quella parete il dipinto è stato sostituito da una grande televisione».
In sala qualcuno ha riso, inclusa me: un desolato risetto carico di nostalgia.
A casa, invece, ho aperto Instagram e sono andata a guardare le cose che posta Trump (o qualcuno dei suoi), che generalmente scorro evitando di mettere a fuoco.
Tipo queste.



Sono, semplicemente, rozze. Grossolane, brutte nei colori, senza gusto se non quello di un celodurismo da America della Rust belt che scola lattine di birra sul retro di un pick up.
Stanno alla classe come gli strilli di copertina dei magazine degli Anni 80, alla sottigliezza di pensiero quanto Rovazzi o Bello Figo, all’eleganza quanto la visiera dritta al Borsalino.
E non è solo questione che l’elettore di Trump, quello cui lui si rivolge scompostamente davanti al maxischermo che fu quadro oggi sempre sintonizzato su Fox News, è sensibile solo (o particolarmente) a questi tipi di messaggi, essendo l’elettore stesso celodurista, incastrato negli anni 80, aspirazionalmente milionario ma senza un centesimo per andare al cinema.
No, nella scelta comunicativa di Trump c’è di più: c’è Trump.
Non è una scelta meditata: è lui che deborda. Lui, quello che ha sposato Ivana Trump e che delle donne racconta di afferrarle per i genitali (l’ho scritta bene: I grab them from the pussy suona un po’ diverso). Che ripete 30 parole da scuola media compulsivamente (nasty! sick! bad !good! nice! TUTTE MAIUSCOLE, ovviamente), che si addormenta davanti alla tivù con il telefono in mano e gli scappa di twittare Covfefe digitando a caso, perché non ha nemmeno l’autocontrollo necessario a capire quando sta per crollare e mettere giù lo smartphone. Che rifiuta di leggere documenti della Cia più lunghi di mezza facciata (meglio se glieli riassumono a voce) e articola il pensiero in 140 caratteri massimo.
Insomma, la comunicazione di Trump è lo specchio di Trump, e ne rappresenta meglio di qualsiasi analisi la superficialità.
Obama trasmetteva un’immagine, anche grazie agli scatti di Souza: semplice ma raffinata, popolare ma di classe, identitaria ma inclusiva. Trump entra nei social media con la bomba H, ogni post è un piccolo ordigno nucleare che annulla la possibilità di interrogarsi, di diventare curiosi, di coltivare la fantasia.
Un giro su Instagram, probabilmente, restituisce il personaggio Trump molto più di tutto quello che ne scriveranno i giornali e i biografi. Ha il pregio di togliere i dubbi: lo puoi quasi toccare, lo vedi grande, grosso e goffo, caricaturale in gesti sempre uguali, sempre un po’ troppo.
Il paragone con le immagini di Obama è così feroce da essere quasi intellettualmente insostenibile: pare di aver fatto un salto indietro di tre decenni, prima che instagram e le serie tivù riuscissero a livellare verso il medio anche i gusti dei senza speranza, per pura emulazione.
A breve – penso (spero) – uscirà una semiologia dell’immagine di Donald Trump. Purtroppo all’università non ho studiato abbastanza per scriverla io: sempre dopo ci si accorge di come si è sprecato il tempo.
[in compenso, con Gabri abbiamo creato questo: esercizi di controcultura mainstream]
Non solo bio
Posted by gea in gea and the city, il lavoro logora chi non ce l'ha on July 10, 2017
Lo ammetto: sono diventata sospettosa delle bio, non mi piacciono affatto.
Bio, e non biografie: la differenza esiste, nel linguaggio a cui siamo abituati. Le biografie sono scritti lunghi, tendenzialmente (auspicabilmente) di personaggi molto noti di cui scavano dettagli meno noti, quasi ineluttabilmente agiografie ma con un po’ di spazio per i bassi, prima o dopo gli alti.
Le bio sono la versione condensata, molto in voga sui social, sulle quarte di copertina, nelle presentazioni di festival, interventi, blog, giornali. Sono tendenzialmente agiografiche anche loro, e ancora non so se sia una specie di illusione ottica obbligata – la sinteticità comprime i bassi: restano solo gli altri – o una necessità di marketing di sé nell’epoca in cui anche la battute su Twitter devono essere capitalizzate. O forse un po’ di entrambe.
Quindi le bio non mi piacciono, anzi, m’affaticano proprio: m’irrigidisco quando leggo quelle degli altri e m’imbarazza scrivere la mia. Il che, peraltro, a lungo non mi ha impedito di declinare la tendenza agiografica, pur riconoscendola: fino a pochi istanti fa, prima che decidessi questo intervento, questo sito recitava così.
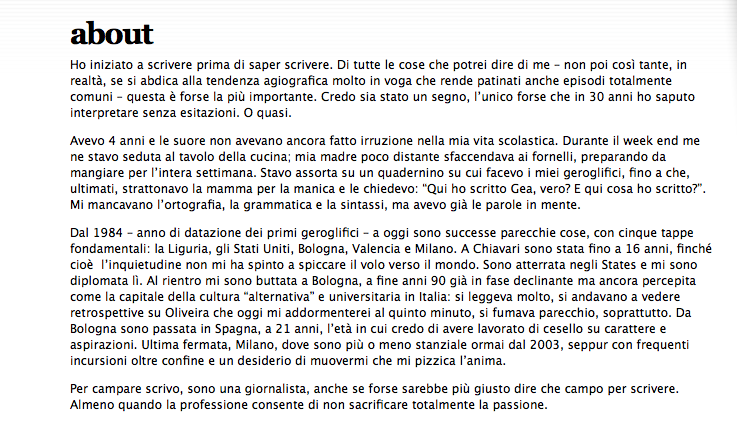
Non molto, in realtà, e soprattutto assolutamente vero, con quel punto di lirismo che aiuta il lettore a figurarsi una biondina con gli incisivi traballanti al tavolo della cucina. Ma tra quella bambina e la me stessa di oggi ci sono in mezzo indecisioni, insicurezze, dimissioni, lavori presi senza convinzioni, scritti probabilmente mediocri, decisioni rimandate e molto altro ancora.
Il problema delle bio è che comprimono tutto quanto. Prima di scrivere un libro, quanti ne avresti voluti iniziare senza riuscire? E dopo averne scritto uno? E prima di imbroccare una cosa giusta, quante ne hai sbagliate? Quante crisi hai avuto, quanti errori hai fatto?
Si dirà: è una bio, mica un saggio o un romanzo del sé. Non è che si debba personalizzare tutto, e troppo. Bisogna dire quello che funziona o ha funzionato: quello per cui qualcuno dovrebbe darti un lavoro o leggerti o comprarti.
Infatti il mio personale scetticismo nei confronti delle bio non riguarda l’onestà nei confronti dei potenziali lettori, quanto il mercato che – giocoforza – determinano.
Prendiamo l’editoria, che è in definitiva l’unica cosa che conosco abbastanza bene da poterne parlare. C’è chi scrive con la mano sinistra e la testa da un’altra parte pezzulli ripresi da comunicati su testate che magari pagano dopo un anno: ma le bio sembrano sempre quelle di novelli Montanelli richiestissimi. Ci sono praticanti che collaborano già con due o tre case editrici, e nella realtà magari scrivono blog non retribuiti. Ci sono quelli che vivono scrivendo comunicati stampa, e si firmano reporter. Mica è una colpa scrivere un blog non retribuito: però a furia di non dirlo potrebbe diventarlo, almeno indirettamente. Infatti il primo che dovesse scrivere la verità – sono giovane, questo mestiere è in crisi nera e il mercato asfittico e senza soldi e non mi paga nessuno – sembrerebbe subito uno sfigato, un perdente: com’è che tu hai una bio così noiosa?
Io, da tempo, ho iniziato a scrivere sui social Wish I could fit a bio, che è la cosa più onesta che posso dire rispetto al fatto che sono una giornalista ma faccio anche cose corporate, che nei giornali a tempo pieno ho scelto di non starci (scelto, sì: unico caso, o uno dei pochi, di assunta a tempo pieno con contratto regolare dimissionaria, rifiutante più di un altro posto del genere), che sono disposta a pagare una certa libertà facendo anche cose non sempre entusiasmanti.
Ma tutte queste riflessioni, ovviamente, non ci stanno in una bio.
Nel frattempo, insomma, ho deciso di espandere la mia ma anche di comprirmela (niente ghirigori e lirismo), in due lingue. Definiamolo un punto di partenza, finché non troverò un metodo migliore. Intanto, la trovate qui, con tanti saluti alla biondina al tavolo della cucina (eri bella, comunque, eh).